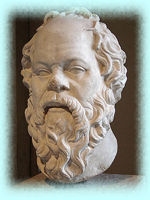ATTILIO QUATTROCCHI
SOCRATE E LA TRADIZIONE INIZIATICA
———-
1 – IL ‘DEMONE’ DI SOCRATE
Una testimonianza concorde circa Socrate ci riferisce che il filosofo affermò sempre in modo molto esplicito che sin da fanciullo era assistito nel prendere varie deliberazioni da una ‘chiaroveggente’voce interiore, voce di un ‘demone’ che lo tutelava e lo guidava secondo principi di prudenza, opportunità e moralità.
E’ questo il più grande ‘enigma’ della sua personalità e del suo vissuto.
Nelle credenze della Grecia antica con quel termine, dàimon (in latino tardo daimonium), s’intendeva un essere intermedio tra l’uomo e la divinità, di natura benigna o maligna, in sostanza un ‘genio’, un’entità vivente in un mondo ‘sottile’, ‘invisibile’, ma collegato in qualche modo al piano ‘materiale’ dell’essere.
A volte s’indicava la stessa anima dell’uomo, la sua psiche, come una realtà ‘demonica’ in quanto di natura ‘spirituale’ e di origine ‘divina’.
Con ciò ci si riconnetteva alla nota tesi sapienziale per cui lo spirito dell’uomo, la sua ‘coscienza’, è un ‘demone’ che solo provvisoriamente ‘abita’ in un corpo ‘materiale’ in quel breve intervallo tra la nascita e la morte che noi esseri umani chiamiamo ‘vita’ per poi continuare la sua esistenza in una dimensione oltremondana da cui spesso ritorna ad ‘incarnarsi’(è la nota dottrina della ‘metempsicosi’, dal greco metempsychosis che letteralmente indica il procresso per il quale la psyché va oltre-metà- e dentro –en- un corpo).
Spesso, più genericamente e meno ‘personalisticamente’, il termine si usava per indicare una generica ed informale ‘potenza’, una ‘forza’ metafisica dotata di una propria consapevolezza ed identità non comparabili con quelle umane ma avente la capacità d’incidere sul mondo degli uomini, di consigliarli o di forzarli nei loro comportamenti.
E’ da tale concetto che ancor oggi si usa ( ma solo in senso figurato…) un’espressione come quella per cui una persona può essere indicata ad esempio, come ‘posseduta’ dal ‘demone’ del gioco; in tale contesto ‘psicologistico’ il termine sta ormai semplicemente ad indicare una passione travolgente, un impulso misterioso a cui una persona non riesce a sottrarsi, motivo per cui viene sentito come ‘estraneo’.
Storicamente, poi, con il trionfo del cristianesimo, il termine ha assunto solo una valenza negativa per il ben noto atteggiamento della nuova religione per la quale gli dei e le entità delle religioni ‘altre’ non potevano che essere principi del male essendo la Verità unicamente ed interamente contenuta solo nella propria dottrina (ortodossia) oltre che nella propria morale e nel proprio culto (ortoprassi).
Ma, ciò detto, che cosa voleva dire esattamente Socrate quando dichiarava di essere assistito da un ‘demone’?
Naturalmente tale affermazione è stata variamente interpretata dagli studiosi moderni: sostanzialmente ci si è chiesti se egli abbia voluto semplicemente utilizzare una ‘metafora religiosa’ con una funzione educativa o se, piuttosto, non si riferisse ad un effettivo ed eccezionale contatto con una entità spirituale.
Per lo più gli storici della filosofia – e non c’è da stupirsene- hanno tentato di ‘leggere’ quella ‘figura’ in una chiave ‘razionale’ e ‘moderna’, riducendola alla mera ‘voce della coscienza’, insomma a quel ‘senso morale’, che di per sé non implica alcuna sua fondazione nella realtà metafisica. Tale interpretazione è in effetti conforme e conseguente alla loro tesi per la quale il messaggio di Socrate ( a differenza di quello platonico) è tutto collocabile nella pura dimensione umana.
Ma se si fa’attenzione ai testi antichi e se si usa il ‘senso storico’ nel dovuto modo, cioè, in tal caso, senza ‘pregiudizi’ naturalistico-razionalistici, tale interpretazione ‘profana’ risulta essere più frutto della tipica ‘idiosincrasia’ della cultura occidentale moderna verso tutto ciò che è ‘sacro’ e ‘sovrannaturale’ piuttosto che di una lettura ‘spassionata’ ed ‘oggettiva’ delle testimonianze antiche.
Insomma il problema non è quello di far dire surrettiziamente a Socrate quello che noi, figli della scienza e della razionalità, pensiamo (rendendolo con ciò ‘attuale’ ed ‘accettabile’), quanto invece quello di comprendere che cosa quel filosofo intendesse effettivamente dire col suo riferirsi al demone.
In realtà l’occidente, che di Socrate ha accolto pressoché esclusivamente il messaggio etico e la fondazione dialettica della logica, non riesce a comprendere come il pensatore abbia potuto o, quantomeno, tentato di conciliare, oltre che nella propria persona anche nel suo pensiero, la dimensione razionale dell’uomo con l’istanza ‘religiosa’, ‘sacrale’, ‘mistica’.
Tale riduttività interpretativa ha fatto sì che la ’ordinaria’ lettura del pensiero socratico abbia marginalizzato o addirittura ‘espunto’ un aspetto della sua personalità e del suo messaggio che risultano invece fondamentali.
Un Socrate che parla con un ‘demone’, un Socrate ‘sciamano’ è quanto di più lontano si possa concepire rispetto alla ‘immagine’ che di lui si è fatta l’occidente.
E invece…
Nella stessa apologia che pronunziò di fronte al tribunale della sua città egli riferì proprio al consiglio della sua ‘entità’ sovrumana la decisione di non partecipare alla vita politica e la definisce come un “qualcosa di divino e demoniaco”( 31c), così come altrove (Rep.,496c) ne parla come di un “segno divino”.
In particolare nell’Apologia Socrate non si riferisce mai a quella entità con la forma sostantivata: “il demone”(to daimònion) ma sempre in forma aggettivale, sottintendendo il termine “segno”.
La voce dell’entità è quindi sostanzialmente per lui il segnale, il consiglio, l’indicazione del Dio. Ma questi è il Dio dei filosofi, svincolato dal rozzo antropomorfismo radicato nella tradizione mitologica ed è inteso quindi da lui come l’Essere Supremo, come il Nous di Anassagora, cioè la Mente che governa il mondo, o come il Dio unico di Senofane.
Quando poi Socrate fa riferimento a Delfi, cioè a quel santuario che l’aveva indicato come l’uomo più saggio della Grecia, è evidente che l’espressione ‘il Dio’ allude ad Apollo come aspetto ‘particolare’ della Divinità, quale nume della mantica.
A suo dire, la volontà divina gli giungeva sotto forma di una “voce interna”(cfr.40b,c, 41d). E’ celebre il passo dell’Apologia in cui rende pubblico ed esplicito tale suo intimo segreto:
“Forse potrà parere strano che io vada in giro e mi dia tanto da fare per dare consigli a questo e a quello in privato, e se poi si tratta di dare consigli in pubblico alla città e di salire sulla tribuna per parlare al popolo, allora mi manchi il coraggio. E la ragione di questo me l’avete sentita dire più volte e in più luoghi, che c’è dentro di me non so che spirito divino e demoniaco; quello appunto di cui anche Melèto, scherzandoci sopra, scrisse nell’atto di accusa. Ed è come una voce che io ho in me fino da fanciullo; la quale, ogni volta che mi si fa sentire, sempre mi dissuade da qualcosa che io sto per fare, e non mi persuade mai”(31c, d).
E’ molto significativo il riferimento del filosofo all’atto di accusa sottoscritto da Melèto: se non s’intendesse l’espressione di Socrate come un inequivoco riferimento ad una ‘entità sottile’appartenente alla dimensione metafisica, non si potrebbe intendere affatto l’imputazione con cui viene trascinato in giudizio.
Infatti l’accusa di ‘empietà’ (asébeia) per aver voluto introdurre “nuovi demoni” (kainà daimónia) in Atene non poteva essere intesa che come la presuntuosa e blasfema intenzione del filosofo d’innovare la vita religiosa della città, sovvertendo così gli antichi culti, le venerabili credenze e gli atavici costumi su cui la polis aveva edificato nel tempo la sua grandezza.
Socrate viene accusato e processato per essere un pericoloso ‘eretico’ o persino un ‘ateo’ che non “riconosce” gli dei tradizionali o non ne riconosce affatto, corrompendo con ciò stesso i giovani.
Secondo la testimonianza platonica proprio nel contraddittorio con Melèto avvenuto nell’ambito del processo, Socrate, incalzando il suo accusatore con la sua abilità dialettica, lo costrinse ad una palese contraddizione, avendogli imputato nel contempo di credere e di non credere agli dei: infatti come lo si poteva dapprima accusare di voler introdurre nuove divinità ad Atene e poi dichiararne un radicale ateismo? Il riconoscimento dell’esistenza di dèmoni comporta infatti il riconoscimento dell’esistenza degli dèi, poiché i dèmoni –afferma Socrate- o sono essi stessi dèi, o sono figli di dèi (27 a-e, 28 a).
Sono pertanto gli stessi accusatori a dare al termine daimònion il significato ‘realistico’ di entità divina oggetto di possibile venerazione e culto.
E tale significato ‘letterale’ Socrate, si badi bene, non lo contestò.
Egli si limitò a replicare che la missione filosofica a cui si sentiva ‘vocato’ gli era stata indicata dal Dio per il bene suo e della città: ogni sua azione così come ogni consiglio del dèmone erano infatti volti ad ‘impedire che si commettessero ingiustizie’e che si trasgredisse la legge.
A tale compito di divino ammonimento egli non era disposto a venir meno neanche per paura della morte; infatti disse:
“Voi lo sapete bene, o Ateniesi, che se da un pezzo io mi fossi messo ad occuparmi degli affari dello Stato, da un pezzo anche sarei morto e non avrei fatto nessuna cosa utile né a voi né a me…di fronte a ciò che è giusto io non sono uomo da cedere per paura della morte a nessuno; (voi sapete) che, pur di non cedere, sono pronto anche a morire” (31d, 32a).
Nell’Apologia platonica è lo stesso Socrate a motivare la sua serena accettazione della condanna a morte con la radicale fiducia nel dèmone il quale non gli ha suggerito di evitare il processo, fuggendo, ad esempio, in esilio: “Quella mia solita voce profetica, quella del dèmone, per tutto il tempo passato io la sentivo continuamente e ad ogni occasione; e sempre mi si opponeva, anche in circostanze di poco conto, solo che stessi per fare qualche cosa che non mi riuscisse bene: Oggi m’è avvenuto un caso, lo vedete anche da voi, di quelli appunto che si possono giudicare, e la gente giudica, gli estremi dei mali. Ebbene, né a me stamattina quando uscivo di casa si oppose il segno del dio, né quando salivo qui sul tribunale, e nemmeno durante la mia difesa, in nessun punto, ogni volta che ripigliavo a parlare. E sì che più volte, in altri discorsi, mi fermò la parola anche a mezzo. Ora invece, per tutto questo processo, qualunque cosa stessi per fare o dire, non mi dette cenno mai di nessunissima opposizione, E allora, la ragione di questo silenzio quale devo pensare che sia? Ve la dirò, questa: che il caso capitatomi oggi deve essere sicuramente un bene; e certo non pensano rettamente quanti di noi ritengono che il morire sia un male. Ho avuto di ciò una grande prova: non è possibile che il segno consueto non mi si sarebbe opposto se quel che stava per accadermi non avesse dovuto essere un bene”(40a-c).
Per Socrate la funzione del dèmone era stata per tutta la vita quella di stimolarlo e guidarlo passo- passo nella missione filosofica; Platone lo testimonia anche nel Teeteto (151c) dove è quell’entità a proibirgli di sottoporre alla sua maieutica alcuni di coloro che lo seguono (cfr. Fedro, 242b-c).
Se la testimonianza di Platone circa la natura metafisica ma nel contempo ‘realistica’ del demone è, a ben vedere, già di per sé inequivoca, quella di Senofonte è ancor più chiara ed esplicita.
Costui riconosce a Socrate, proprio in virtù del suo dialogare con quell’entità, la stessa capacità profetico-divinatoria della Pizia. Infatti per rendere comprensibile quel ‘fenomeno’ e quella particolare facoltà del filosofo fa riferimento ad altri tipi di divinazione utilizzati dagli esseri umani, quali l’osservazione del volo degli uccelli, l’attento ascolto dei tuoni, ecc.(Apologia di Socrate, 12-13).
Per Senofonte gli avvertimenti del demone si manifestavano in forma di parole ‘chiarudite’che assumono la forma non solo di ‘proibizioni interiori’(come Platone tendeva ad interpretarle) ma anche quella di consigli ‘propositivi’; a riprova del tutto lo stesso Senofonte attesta il verificarsi nella vita del filosofo di prodigi, ‘segni’, eventi, pregni di significato ‘provvidenziale’.
I suggerimenti del dèmone orientavano l’azione di Socrate non solo in quelle occasioni in cui doveva operare scelte morali ma anche nelle vicende più minute ed apparentemente più insignificanti della sua vita. In tali casi la sua ‘voce interiore (a volte in modo ‘enigmatico’) dava delle indicazioni che si dovevano intendere alla stessa stregua dei ‘responsi’ della mantica antica.
Senofonte così non ha dubbi nell’intendere il dèmone socratico come una vera e propria entità sovrumana e che tale la considerassero tutti i contemporanei del filosofo è dimostrato da quanto lui ci racconta: spesso delle persone ponevano delle domande a Socrate per interrogarne in realtà il demone; in effetti il loro stesso contenuto presupponeva l’ipotesi da parte dell’interrogante di una capacità chiaroveggente del pensatore (Mem. I, 1,4).
In tale linea interpretativa ‘magica’si collocarono, del resto, tutte quelle opere che nei secoli successivi videro nel saggio ateniese un facitore di miracoli.
Ad esempio Cicerone, nell’opera dedicata alla divinazione, ricorda episodi attestanti le facoltà paragnostiche di Socrate come quello per cui in una precisa circostanza sconsigliò Critone di andare in campagna dove in effetti, essendovisi tuttavia recato, rimase ferito da un ramo d’albero ad un occhio (“Non mi hai ascoltato quando ti ho sconsigliato di andarci – disse- seguendo io, come sono solito, un presagio divino”); o come quell’altro per cui Socrate, trovatosi in fuga con il comandante Lachete dopo la sconfitta nella battaglia di Delio, giunto ad un trivio non volle continuare la sua strada con lui perché ne era trattenuto dal dèmone; in effetti coloro che non seguirono il suo consiglio vennero poi tragicamente a scontrarsi con la cavalleria nemica.
L’Arpinate inoltre fa riferimento alle molte altre testimonianze di quel tipo raccolte da Antipatro di Tarso (“Permulta collecta sunt ab Antipatro, quae mirabiliter a Socrate divinatae sunt. Quae praetermittam…”)(De divin., I, 54, 122-124).
La interpretazione ‘sovrannaturalistica’, ‘medianica’, ‘magica’, ‘esoterica’ – comunque la si voglia qualificare – del dèmone avanzata da Senofonte, non è per nulla contraddetta dallo stesso Platone che nell’Apologia mette in bocca al filosofo l’espressione: “…mi parlava la solita mantica, quella del dèmone” (40a).
Plutarco che assieme ad Apuleio ha dedicato al tema un’opera specifica (De genio Socratis) ci ricorda ad esempio che un giorno il filosofo, mentre camminando interloquiva con Eutifrone “…all’improvviso fermandosi e tacendo, stette raccolto in se steso per lungo tempo” poi cambiò strada invitando gli amici che lo accompagnavano a fare altrettanto. Alcuni seguirono il suo consiglio, altri continuarono a procedere per la stessa via ma vennero di lì a pochi istanti travolti da un gruppo di maiali che l’insudiciarono. Teocrito, che nell’opera di Plutarco si dichiara testimone dell’accaduto esprime nell’opera la sua meraviglia “per il fatto che mai il dio trascura Socrate e lo abbandona”. Il commento di Plutarco stesso è che il saggio ateniese “era guidato da un potere superiore e da un maggiore intendimento verso il Bene” (De genio Socr., 9-12).
E’ sempre tale autore a raccontare un vero e proprio prodigio divinatorio di cui fu protagonista il padre di Socrate il quale, avendo interrogato l’oracolo mentre il figlio era ancora molto piccolo, ebbe l’indicazione di non imporre maestri al figlio perché dal Dio era destinato nella vita ad “avere una guida in se stesso” (20-21).
Concordi con tale ‘lettura’ del genio socratico (che non è quindi da intendere come una generica, astratta ed intellettualistica figura concettuale per indicare il sentimento morale dell’uomo), furono sia Apuleio nel suo De deo Socratis, sia tutti gli esponenti dei vari ‘platonismi’ del II e III secolo d. C., sia autori più tardi come Giamblico, Siriano e Proclo.
2 – IL DEMONE, IL LOGOS E L’ESPERIENZA METAFISICA
Socrate che parla ai discepoli prima di morire con la cicuta (David)
Di fronte al tribunale che lo giudica Socrate difende contro ogni accusa di empietà o ateismo la sua profonda religiosità, cionondimeno è chiaro che tale ‘fede’ nel comando interiore, proprio per le sue peculiari caratteristiche, non fa venir meno né sminuisce la centralità della sua capacità critica.
E’ evidente che il dèmone a Socrate consiglia azioni morali ma ciò non implica, come si è detto, che per tale motivo esso debba essere considerato solo una ‘finzione’ dietro cui egli abbia celato la sua ‘razionale’ coscienza etica.
Al contrario: per il filosofo la voce ‘divina’ che lo ispira s’identifica del tutto, a causa della sua stesso origine, con la voce della moralità razionale.
Questa ha quindi il proprio fondamento nella dimensione metafisica.
Socrate, infatti sembra così argomentare: se Dio è in sé Coscienza e Razionalità universali, è il Bene, è ciò che dà ordine, misura ed equilibrio al Cosmo, così anche la ragione umana, il divino in noi, non solo tende alla conoscenza ma deve anche portare la giustizia, l’ordine e l’armonia nel mondo finito degli esseri umani.
Tale scopo la ragione lo consegue guidandoli a trascendere le passioni distruttive attraverso l’autocoscienza e il dialogo.
L’ ispirazione sovrannaturale che a Socrate giunge attraverso il dèmone, non solo stimola e guida l’uomo a conoscere razionalmente la struttura ordinata del mondo, ma lo assiste anche nel trovare una saggia misura nei comportamenti.
Solo tale individuale equilibrio razionale – morale e divino nel contempo- può creare nella società stabilità e pace, fondando saldamente sia la moralità privata che l’ eticità pubblica e a tale fine (etico e metafisico nel contempo) Socrate consacra la sua stessa vita.
La ‘oggettiva’ esistenza di un ‘nume tutelare’, di uno ‘spirito guida’ con cui Socrate ha un intimo colloquio comporta quindi il fatto che quello per la sua stessa ‘natura’ lo guidi al Bene secondo la misura della razionalità.
Per Socrate il Bene ed il Razionale sono il ‘divino’.
L’uomo che si dedica alla Conoscenza e alla Bontà manifesta la sua essenza spirituale, la sua natura profonda.
Pertanto ogni vero bene ha un fondamento nella razionalità cioè nella Coscienza e nella Conoscenza.
La morale per Socrate non è che l’insieme delle norme che devono guidare razionalmente la nostra condotta imponendosi alla impulsività, alla passionalità, alla istintività, cioè alla nostra natura ‘animale’ intrinsecamente egoista e violenta, capace di togliere la serenità all’animo e la pace alla polis.
Del resto proprio nell’individuo che è ‘succube’ delle sue passioni l’io razionale perde la sua ‘presa’, abdica rispetto al suo compito, subisce, non afferma la sua ‘dignità’.
L’io sovrastato dalla passionalità perde la sua ‘lucidità’, la sua capacità di comprensione e di giudizio, dunque si ‘snatura’.
L’io che si sviluppa attraverso l’introspezione, al contrario, è capace di ‘prendere le distanze’ dalle pulsioni più violente e se si esercita a tal fine non ne viene più turbato.
Insomma consegue quel sentimento di trascendenza e di superiore serenità che è tipica del saggio, una imperturbabilità che non è indifferenza ed insensibilità ma conquistata capacità di visione spirituale.
Tale ‘libertà interiore’ è una conquista senza la quale l’io è sopraffatto e soffre; appunto: patisce.
Questa sofferenza è insita nella passione ed anche lessicalmente fa tutt’uno con essa perché l’individuo, l’io che subendola non è padrone di sé, autonomo, autarchico, è schiavo e non realizza la sua profonda, strutturale aspirazione alla libertà; soffre pertanto nella sua ‘essenza’, ne sia o meno consapevole…
Ecco perché non può proprio in linea di principio esserci contrasto nello spirito di Socrate tra il consiglio del dio e la sua personale coscienza morale.
Ragione e Religione, così come ‘morale religiosa’ e ‘morale laica’, dunque, non sono scissi in Socrate; lo saranno in occidente col cristianesimo che alle verità di ragione opporrà le verità di fede, attribuendo alla divina rivelazione dottrine e norme incompatibili con la razionalità umana, ed imponendo l’assenso al dogma.
In tal modo la religione venuta dalla Palestina ridusse la filosofia ad ‘ancella’ della teologia, ponendo il fondamento ed i criteri della vita religiosa ‘fuori’ dell’uomo, cioè fuori della sua coscienza e della sua intelligenza, fuori del logos.
E sarà così anche se – e proprio perché – i cristiani identificheranno il Logos con il loro presunto Salvatore, l’ebreo Gesù, e solo con lui, snaturando e tradendo il concetto greco che quel principio ‘divino’ lo vedeva immanente in ogni essere umano come sua natura profonda.
Ma non possiamo comprendere Socrate (e la Grecia…) attraverso le categorie religiose dell’occidente cristiano e, ancor meno, attraverso quelle dell’occidente materialistico moderno.
Non solo per Socrate ma per la filosofia greca in generale il logos umano è parte o riflesso del Logos divino e per questo il principio della salvezza religiosa è immanente in ciascun uomo, indipendentemente da ogni fede specifica o appartenenza confessionale: è questa, a ben considerare, una vera forma di universalismo antisettario ( e dunque di vero ‘cattolicesimo’ considerato che il termine katholikós in greco significa appunto ‘universale).
Ed è stata proprio la filosofia a ‘depurare’ in Grecia la religione da ogni forma di rozzo ed irrazionale antropomorfismo, mitologismo o etnicismo, riconducendo la ‘pietas’ alla pura ricerca del Vero e del Bene (di cui il Bello è il ‘preludio’ sul piano materiale).
Va così precisato che il termine logos nella speculazione ellenica non indica solo il pensiero dialettico capace di cogliere attraverso il concetto l’essenza di ogni fenomeno e dunque anche quella del fenomeno religioso, ma anche – e più specificatamente, poi, nel contesto della metafisica – la facoltà che si manifesta come coscienza intuitiva del divino in noi, cioè come coscienza mistica.
La ricerca dell’essenza, cioè lo sforzo che compie il logos per la sua intima e connaturata ‘virtus’, è già da interpretare come ricerca dell’universale oltre il particolare , dello spirituale oltre il sensibile ed il fenomenico, dell’invisibile oltre il visibile, dell’unità oltre ogni molteplicità.
Per questo dialetticamente non c’è concetto più alto di quello dell’Unità Suprema, dell’Uno-Tutto in cui si risolve, si riconduce e trova significato ogni individualità ed ogni dualità, mentre esperienzialmente ( e ‘corrispondentemente’!) non c’è nessuna condizione dello spirito umano che possa andare oltre l’Unione mistica col Tutto divino.
Con l’esperienza mistica l’unità pensata (filosofia) viene percepita (sofìa).
Per cui, sic stantibus rebus, non si può non cogliere nel movimento stesso del lógos, nella sua intima dynamis, un’ aspirazione immanente alla trascendenza delle forme che si esprime attraverso la tensione religiosa e metafisica.
Ecco perché tutte le tradizioni iniziatiche invitano a cogliere la forza basale del pensiero (la sua radice divina) attraverso l’introspezione.
Il lógos ha in sé la forza e la natura della trascendenza.
La tensione conoscitiva del logos è anche una tensione religiosa.
Essa è sentita dall’uomo a livello emotivo come aspirazione, amore, desiderio di realizzazione che non si appaga nel fenomenico e nel finito.
La ’forza’ del logos è quella di un eros che aspira all’Assoluto.
Conoscendo quella Forza si conosce Dio, è essa stesso Dio in noi: est Deus in nobis.
3 – CONOSCI TE STESSO
“Conosci te stesso” in caratteri greci
In tutto ciò Socrate è sempre fedele al precetto delfico ‘Conosci te stesso’, che quindi va inteso nella sua duplice accezione, cioè come un invito sia alla consapevolezza dei propri‘umani’ limiti, sia alla attiva pratica interiore volta a scoprire la dimensione essenziale, ‘apollinea’, cioè ‘divina’ della propria coscienza.
Tale pratica consiste appunto, al suo primo stadio, nell’esercizio della ‘dialettica’.
C’è una linea di assoluta continuità in tal senso che va da Socrate a Plotino attraverso Platone.
La mente, il processo discorsivo, la dianoia, non è tutto.
L’articolazione rigorosa del ragionamento non si identifica con la filosofia, nel senso che non ne è lo scopo.
La filosofia se non diventa ‘sofia’ non ha significato, non ha valore, non perviene alla sua dichiarata meta, al suoi fine strutturale, il quale è nell’etimo stesso, nel suo definirsi.
Il precetto di Apollo ha naturalmente un valore sacro, indica la necessità di una presa di coscienza (da cui nasce il sentimento ‘religioso’) ma anche una di via ‘iniziatica’da percorrere.
Per questo Socrate ribadisce a più riprese, con assoluta ed inequivoca chiarezza l’identità del fine della filosofia con quello dei misteri.
L’autoconsapevolezza prescritta dal dio di Delfi non può né vuole essere ‘paralizzante’ ma, per la sua stessa origine metafisica, deve corrispondere soprattutto ad un criterio ad un ‘metodo’ di sviluppo interiore (significativamente il termine greco méthodos è composto dalla preposizione metá che indica un ‘superamento’ e hodós che significa ‘via’, dunque è ‘un cammino che porta oltre’).
I limiti dell’umano sono valicabili, poiché noi, ‘umani’, siamo, nella nostra essenza, ‘simili al dio’.
Il percetto delfico è un precetto religioso.
La ‘somiglianza al dio’ (homoìosis theò) che caratterizza la condizione umana in quanto dotata di consapevolezza e razionalità è sia il tema fondamentale che il presupposto stesso della via spirituale indicata da Platone in tutti i suoi dialoghi. E non si dimentichi mai che il protagonista di tali opere, colui che espone tali dottrine, è sempre e comunque il suo Maestro, Socrate.
Così prendere coscienza dei propri limiti conoscitivi significa ‘religiosamente’ assumere come presupposto di ogni vita interiore la chiara percezione dei limiti della mente.
Solo conoscendo in modo ‘realizzativo’, cioè vivo, partecipato ed esistenziale, tale condizione si può sentire l’impulso al suo trascendimento ed iniziare così il percorso ‘mistico’ che conduce l’uomo dal mondo sensibile a quello meta-sensibile.
Così ogni impulso animale, ‘corporeo, si sublima (‘mette le ali’, dice il poeta Platone) poiché si pone al servizio della Conoscenza.
Eros e Logos quando procedono uniti ci proiettano nella dimensione del ‘sacro’.
Amore della Sofia è Amore per la Trascendenza, aspirazione a quella Beatitudine che si può provare solo oltre il mondo delle forme sensibili, fuori del ciclo delle nascite e delle morti.
Tale evoluzione non avviene e non può strutturalmente avvenire attraverso le catena di ragionamenti che la mente ‘dialetticamente’ costruisce ed in cui, in genere, si esaurisce l’attività ordinaria, ‘umana’ della coscienza.
Una cosa è la coscienza, altra il pensiero.
Il ‘pensiero’ è umano, la coscienza, la ‘pura’ coscienza è ‘divina’.
E la coscienza è ‘pura’ quando sa distaccarsi dal mondo dei sensi e sussistere ‘libera’, non ‘contaminata’.
L’uomo che ‘ragiona’, che ‘astrae’, che elabora una catena sequenziale di ragionamenti e tutto si concentra su tali procedure ‘interne’ è già sulla via dello Spirito perché, al fine di comprendere la Realtà, si è già allontanato deliberatamente dall’immediata percezione sensibile a cui non si dà più con una ingenua fiducia.
Si è poco inteso sinora tale valore e potere di ‘trasformazione sottile’ della ‘riflessione’ nel contesto dell’intera storia della filosofia greca.
Tale esercizio del logos opera già di per sé una ‘catarsi’, una ‘palingenesi’, se ne sia più o meno consapevoli.
Per questo si può dire che nella tradizione socratico-platonica-plotiniana il primo grado del percorso spirituale è costituito dall’esercizio dialettico.
Esiste un percorso ‘naturale’ della coscienza che inizia dalla ‘dialettica’ (dunque dalla filosofia) e perviene in conclusione alla theoria contemplativa (dunque all’esperienza mistica).
L’attività della riflessione è ‘umana’, l’attività della contemplazione è ‘divina’.
La contemplazione è nell’arresto del pensiero, ‘implica’ l’arresto del pensiero.
La coscienza, divenuta libera e matura attraverso la pratica contemplativa è capace di penetrare (intuire) direttamente il mondo, di cogliere la essenza invisibile del mondo.
Alla capacità d’intuire il mondo sensibile si affianca la più profonda capacità d’intuire il mondo sovrasensibile.
E’ una intuizione intellettuale ‘pura’, e la si può definire tale perché capace di conoscere il mondo prescindendo dai semplici e limitanti dati della sensibilità.
Per conoscere la nostra stessa ‘essenza’ è necessario andare oltre la discorsività dialettica, cioè oltre la mente.
Bisogna scoprire, anche qui, la forza e la dimensione del ‘puro’ pensiero, cioè del pensiero senza contenuti né sensibili, né immaginativi.
A tale condizione perviene Socrate quando ( come ci testimoniano le fonti) s’immobilizza.
Per l’Uomo tale consapevolezza ‘separata’ è la pura Autocoscienza.
Tale coscienza ‘separata’ rende possibile e prelude, avvia, alla ‘contemplazione’ (theoria), cioè alla diretta intuizione (noesis) di Sé, del Mondo e del Sovramondo.
La contemplazione sviluppa un tipo di conoscenza diverso da quello ordinario, in cui soggetto e oggetto sono insuperabilmente separati, cioè realizza una conoscenza per identità in cui il soggetto entra dentro l’essenza invisibile, ‘sottile’ dell’oggetto, si fonde, in qualche ‘ineffabile’ modo, con essa.
Non c’è da stupirsi, dunque, del fatto che colui che si sveglia a tale condizione della coscienza senta il bisogno di prendere le distanze dal ‘mondo’ e cercare, almeno agli inizi, quella quiete e quella solitudine in cui e con cui esplorarsi ed esplorare.
Immobilità e silenzio danno forza e sensibilità alla coscienza.
Chi aspira alla Saggezza non vuole essere dis-tratto dalla sua Alta Meta.
Ha bisogno di tutta l’intensità di una concentrazione volta all’interno, all’invisibile.
Lo spirito ‘disperso’ nel mondo materiale deve ‘unificarsi’.
Tale desiderio ontologico ( in cui convergono le aspirazioni sublimanti alla Bellezza, al Bene e alla Verità) è la vera essenza dell’Amore.
Per questo ‘eros è filosofo’ e l’uomo soffre di un’ inestinguibile bramosia di completezza, avverte una sua condizione di profonda privazione, brucia per un fuoco che si può estinguere solo con la realizzazione mistica.
Cupio dissolvi: la coscienza ‘individuale’, vincolata allo spazio ed al tempo, vuole diventare Coscienza Universale.
Da sempre nella tradizione mistica il principium individuationis è la radice vera di ogni male, di ogni errata ed illusoria percezione del mondo.
La radice del dolore nell’essere umano è nella percezione della sua finitezza.
Nel linguaggio religioso tale percezione si tradurrà devozionalmente nell’ammonimento a ‘morire a noi stessi per rinascere in Dio’.
Nel linguaggio ‘filosofico’ si dirà che ‘il finito vuole ritornare all’Infinito’ perché l’individuo intuisce profondamente, anche al di fuori di ogni contesto religioso, che è “dolce naufragare in quel mare” poiché dissolvendo l’io si dissolve con ciò stesso la fonte del dolore esistenziale.
A causa della universalità di questa profonda aspirazione, comunque essa si manifesti e traduca nel vissuto, si può affermare che tutti gli esseri umani sono strutturalmente mistici.
Attraverso l’introspezione – e solo attraverso essa – l’essere umano può cogliere l’essenza ‘divina’ della sua stessa coscienza come pura ed irradiante realtà sovraformale,.
Da qui la centralità del motto delfico che ammonisce all’autoconoscenza.
Ecco perché la ricerca dell’universale attraverso il concetto (cioè, sostanzialmente, la riflessione filosofica) innalza l’uomo dalla religione alla religiosità svincolando l’aspirazione al trascendente da ogni superstizione, fideismo, settarismo e fanatismo, cioè da ogni irrazionalistico particolarismo.
Se la religione in occidente è giunta, anche in età moderna, a tali altezze (ad esempio attraverso la religiosità ‘laica’ o il deismo illuministico) lo deve solo al fatto che è storicamente depositaria della riflessione filosofica della ’pagana’ Grecia.
Per quanto detto risulta del tutto chiaro come il contrasto tra pìstis (fede) e lógos, che ha avuto conseguenze storiche tragiche per l’esclusivismo dogmatico che ne consegue, appartiene solo al cristianesimo e alla sua radice ebraica.
In Grecia se la filo-sofia è collegata col logos come attività associativa e analitico-sintetica del pensiero, la sofìa è collegata all’intuizione mistica metafisica.
Il motto delfico nella verisione latina
La filo-sofia, la parola stessa lo dice, è strutturalmente finalizzata alla sofia.
Il ponte tra la prima forma di attività e la seconda è nell’Io, il quale è nel contempo sia la base della pura attività logica in quanto soggetto che si autopercepisce nel processo conoscitivo e ne organizza il ‘materiale’ ( si pensi all’io-penso kantiano come appercezione trascendentale, suprema unità e funzione sintetica di ogni nostra esperienza) sia la base per un ulteriore sviluppo conoscitivo orientato verso la dimensione non materiale dell’Essere.
L’io che con l’introspezione deliberata si volge su se stesso, si ‘autoconosce’, sviluppa con tale atto di consapevole separazione dal mondo esterno (quello delle ‘intuizioni’ sensibili) le proprie capacità di percezione ‘sottile’.
L’introspezione deve essere concepita come un ‘esercizio’ (in greco: ‘ascesi’…) che sviluppa la capacità di ‘penetrare intuitivamente’ (intuire, dal latino in+ tuēri, ovvero: guardare dentro) tutto ciò a cui volge la sua attenzione.
L’individuo diviene capace finalmente di andare al di là delle forme materiali e di cogliendo di ogni realtà l’intimo dinamismo psichico, vitale e coscienziale.
L’atto interiore deve essere quello di chi osserva se stesso ed il mondo con volontà conoscitiva ma senza ‘appoggiarsi’ ai consueti procedimenti logico-associativi.
E’ un atto ‘contemplativo’ la cui natura è quella di una ‘fissazione concentrativa’ possibile solo quando ci si svincola dai dati sensibili e s’interrompe il dispersivo ed autoipnotico ‘dialogo interiore’ in cui gli individui solitamente sono immersi.
Nella meditazione mistico/contemplativa (questo era il significato originario del termine greco theorìa) ci si separa dal mondo e il pensiero viene sospeso non per cadere in uno stato di ottundimento soporifero ma, al contrario, per intensificare la coscienza, renderla più vigile e penetrante.
Ed è proprio lo stato prolungato d’immobilità fisica a cui Socrate era aduso che, tradizionalmente, sia in Oriente che in Occidente, è stato considerato come lo strumento fisico atto ad agevolare quella condizione dello spirito.
E’ lo stesso ‘atto interiore’ extrarazionale che si manifesta nell’intuizione estetica con cui cogliamo il Bello ma ormai sublimato, cioè fatto ascendere da una dimensione puramente emotivo-sentimentale (correlata al giudizio di gusto, al ‘piacere’ estetico indotto dalle forme materiali) a quella noetica del Vero e pratica del Bene.
L’Arte – in primis quella del ‘genio’ (il dèmone in noi!…) – nasce così dalla ‘mistica’, ‘misterica’, ‘misteriosa’( per quanto si è detto sono tutti sinonimi…) penetrazione intuitiva del Mondo.
L’artista, per la sapienza greca, è infatti un ‘veggente’ in cui la forza dello Spirito si manifesta con la creatività.
Anche il Bene è collegato all’intuizione della dimensione ‘sottile’, infatti è a quel livello che le forme distinte materialmente e separate dal ‘principium individuationis’, vengono percepite come tra loro tutte intimamente collegate al punto che il dolore degli altri esseri lo ‘sento’ come mio; da tale intuizione dell’unità del vivente (che, almeno a livello subconscio è universalmente presente in tutti gli esseri umani) nasce il sentimento di ‘compassione’ che è la base metafisica, appunto, di ogni etica.
Tutta la vita spirituale dei greci fu improntata da tali intuizioni metafisiche che di per sé costituiscono le basi del sapere tradizionale, cioè della philosophia perennis.
Dèmone o non dèmone, per Socrate la ragione, che è il divino in noi, è l’ unico vero giudice delle norme morali perché ne è anche l’origine; insomma se io agisco razionalmente agisco per ciò stesso moralmente e religiosamente.
Per tal motivo non si può scindere la morale dalla religione, anzi si deve cogliere proprio nella morale l’essenza pratica della religione.
Storicamente (e, non è un caso, proprio a partire dal ‘pagano’ Rinascimento) tali intuizioni saranno il fondamento di tutte le libertà civili che si affermeranno nell’occidente occidente
Proprio nel principio della libertà di coscienza e della conseguente libertà individuale di religione si radicheranno, infatti, il liberalismo e la democrazia.
In particolare il mondo delle moderne libertà civili nascerà in Europa dalla riflessione filosofica sulla causa ‘ideologica’ delle sanguinarie guerre di religione tra cristiani cattolici e cristiani protestanti, cioè la pretesa – che li accomunava – di essere detentori di un vero assoluto e del diritto/ dovere d’ imporlo.
Il sentimento e la coscienza ‘socratici’ della nostra umana fallibilità e fragilità saranno indicati come gli unici antidoti culturali e psicologici possibili alla beluina ferocia delle religioni ‘storiche’.
Così pensarono quei saggi europei che sin dal XVI secolo indicarono nei princìpi della libertà di coscienza, del dialogo e della tolleranza le basi di una ‘pace perpetua’ oltre che di una radicale riforma religiosa.
Ma se l’ideale della tolleranza non poteva essere fondato che sul rispetto reciproco della libertà di pensiero, sull’autoconsapevolezza, sul dialogo, sulla responsabilità morale individuale, sulla laicità dello Stato, come non vedere proprio in Socrate il Maestro di un mondo pacificato e saggio in cui ragione e religione possano coesistere?
Bruno,Voltaire, Locke, Kant e quant’altri che si nutriranno di quegli ideali non saranno, sostanzialmente, che suoi discepoli.
4 – IL SOCRATE MISTICO
Se ormai è chiaro che il dèmone non è solo “la traduzione in formule di religiosità popolare dello stesso principio morale” (Giannantoni), va osservato che nella stessa biografia del pensatore c’è un elemento determinante (ma troppo poco o per nulla valutato) che c’indica la sua attitudine ‘mistica’ e consuetudine meditativo-estatica.
Nel Simposio platonico Alcibiade ce lo descrive capace di una tale intensa concentrazione da perdere del tutto il contatto con il mondo eterno, fissandosi in uno stato corporeo d’immobilità così prolungata che di analoghi e ne trovano solo presso le antichissime e tradizionali pratiche mistico-iniziatiche, quali quelle dello yoga induista. L’immobilità in una posizione (asana) è ritenuta in tali contesti come la condizione quasi necessaria per volgere la coscienza verso l’interno, verso gli stati ‘sottili’ della consapevolezza umana, verso cioè la pura dimensione spirituale.
E’ significativo che di tali esperienze interiori Socrate non ci abbia dato una testimonianza esplicita e non abbia tentato di tradurle in un ‘dottrina’: evidentemente ne coglieva la natura irriducibilmente personale ed ineffabile.
Sarà il suo discepolo Platone ad essere più audacemente esplicito sull’argomento, anche se, alla fine della vita, dovrà ben rimeditare sulla possibilità di tradurre le esperienze metafisiche in una ‘ideologia’, in un ‘sistema’ concettuale conchiuso.
Dunque, Alcibiade è testimone diretto di quella straordinaria capacità di concentrazione meditativa che il filosofo dimostrò durante una campagna militare:
“ Socrate tutto assorto in qualche idea ‘era piantato ritto là, fermo dall’alba, meditando; e poiché non ne veniva a capo continuava, ritto in piedi, la sua ricerca: E già era mezzogiorno e alcuni uomini se n’erano accorti e meravigliati dicevano l’un l’altro: ‘Socrate se ne sta lì impalato dall’alba, immerso in qualche pensiero’. Alla fine alcuni Ioni, scesa la era, dopo aver cenato – poiché allora era estate- portarono fuori i giacigli e si misero a riposare all’aperto e nello steso tempo a controllare se stesse piantato là tutta la notte. Egli vi stette finché fu l’alba e si levò il sole. Allora si mosse e se ne andò dopo aver fatto la sua preghiera al sole” (Symp. 220c).
Anche all’inizio del medesimo dialogo, mentre gli invitati arrivano in casa di Agatone, Socrate si raccoglie in meditazione nel vestibolo: “ Se ne sta lì ritto; lo chiamo e non vuole entrare…Questa è la sua abitudine: talvolta si ritira dove gli capita e sta lì ritto” (175 ab).
Esiste dunque un Socrate ‘segreto’, un Socrate che non va in giro per la sua città cercando costantemente il dialogo ed il diretto contato con gli ateniesi per svolgere la sua funzione di educatore, dunque un Socrate loquace, persino, per molti, ciarliero e petulante; al contrario, una lettura attenta delle testimonianze ci dimostra che il Socrate ‘storico’ è quello che, accanto all’attività ‘pubblica’, s’impegna in una intensa ricerca interiore, che per questo sente il bisogno d’isolarsi; un Socrate mistico, dunque ‘silenzioso’ ed intensamente meditativo.
E’ evidente che nel suo contatto introspettivo con la realtà ‘divina’, ‘demonica’, cerca il segreto della sua vocazione e la forza per realizzarla.
Nella sua ricerca della sofìa Socrate rimane però sempre lucidamente consapevole che essa è appannaggio delle divinità: “la sapienza- egli dice ai suoi giudici- è degli dèi”; ma egli è conscio che l’uomo, posseduto dal dèmone della sua ricerca, vuole e può ‘indiarsi’ perché egli stesso, nella sua essenza, proviene da quel mondo: il solo, come affermava univocamente la tradizione religiosa della sua terra, in cui si può essere ‘eternamente felici’.
Ma può il ‘sapere umano’ tradursi ed evolvere verso un sapere divino?
Può la filosofia approdare alla sofia?
Può l’esercizio del logos condurre a quella dimensione sacra che lo sovrasta?
Le fonti ci dicono – e gli storici della filosofia ce lo ricordano costantemente- che Socrate in tutta la vita non ha fatto altro che autolimitarsi ad un sapere ‘umano’ e che questo è stato il carattere fondamentale della sua ricerca speculativa.
Ma come poteva Socrate pensare a questi limiti come realtà invalicabili, lo stesso Socrate che parla col demone, onora l’Apollo di Delfi o che sente la sua stessa vita, come dice ai suoi giudici, una missione voluta dal Dio per insegnare ai concittadini la virtù?
Come poteva Socrate pensare, dunque, che la conoscenza di se stesso non avesse nulla a che fare con la conoscenza del Dio?
Non è Dio stesso la Realtà da cui veniamo e verso cui c’inoltriamo, avvolti come siamo nel Mistero?
Fu proprio un filosofo indiano a porre tali obiezioni a Socrate ed a farlo meditare sull’insensatezza della sua ricerca se essa fosse rimasta chiusa in se stessa, se si fossero pensati come comunque invalicabili i limiti delle nostre possibilità conoscitive.
Aristosseno ci racconta un episodio della vita di Socrate estremamente significativo, in qualche modo emblematico di tutta l’opposizione tra la filosofia occidentale, quella di cui proprio Socrate è stato l’effettivo iniziatore, e la filosofia orientale, filosofia che nella sua essenza, non a caso, è saggezza mistica.
Racconta dunque Aristosseno:
“Socrate incontrò ad Atene un indù che gli chiese quale tipo di filosofia praticava. Socrate rispose che indagava l’uomo, e quello ridendo disse che non si potevano conoscere le cose umane se si ignoravano le divine” (In Eusebio, Praeparatio evang., XI, 3, 28. Per le tecniche meditative socratiche cfr. P. M. Schuhl, L’opera di Platone, Roma, 1977, pp. 35-36, e Festugière, Contemplation et vie contemplative selon Platon, Paris, 1936, p. 71).
L’ambiguità di Socrate è forse tutta in questo: nell’aver da un lato mantenuto concetti ed atteggiamenti propri della tradizione sacrale greca e dall’altro nell’aver tentato una strada alla conoscenza, quella logico-discorsiva, concepita (almeno così sembra a volte, stando alle testimonianze su di lui) come autosufficiente.
Aristotele – ed in qualche misura lo stesso Platone – lo interpretano così.
Socrate, per loro, è l’inventore del concetto e del processo di astrazione.
Ma fu questo il Socrate ‘storico’, quello reale?
Fatto sta che Socrate è vissuto nella filosofia occidentale così come i suoi discepoli lo hanno presentato.
Che si debba o no riferire a Socrate quella ‘tracotanza dell’intelletto’, di fatto da essa sono nate la filosofia e la scienza occidentali così come noi le conosciamo, con le loro grandezze e con le loro ‘incongruità’.
La conoscenza dell’umano e del naturale è divenuta storicamente per l’occidente l’unica conoscenza possibile sino a negare del tutto ed aprioristicamente non solo ogni possibilità di una facoltà quale quella definibile come ‘intuizione intellettuale’ ma anche la stessa esistenza di una dimensione non- fisica del Reale.
Aveva ragione l’indiano a farsi beffe di Socrate: come separare l’umano dal divino?
Conoscere realmente l’uno non è possibile senza conoscere l’altro.
L’uomo che riconosce il Mistero riconosce ciò che trascende le sue possibilità di percezione e le sue possibilità d’intendimento.
A volte, però, sia Socrate che Platone sembrano essere perfettamente consapevoli di tale situazione e sembrano voler allora subordinare l’attività logica a quella intuitivo-spirituale.
Per questo spesso già Socrate ( e poi, ancor più chiaramente, lo stesso Platone) sembra in talune testimonianze non solo riconoscere i limiti della ricerca dialettica ma anche considerarla come radicata nel mondo metafisico e orientata verso di esso e quindi al proprio trascendimento.
L’attività razionale non tende cioè solo a costruire un mondo razionale per uomini consapevoli eticamente e per ciò stesso capaci di costruire una polis armoniosa, essa ci guida (anche se non tutti ne sono pienamente consapevoli) verso quel mondo ‘demonico’ la cui voce risuona nella coscienza di ciascuno di noi.
E’ questo ‘divino in noi’ che l’arte maieutica deve far emergere.
Ed il logos allora, se così inteso, è solo un riflesso sul piano materiale del divino in noi.
Proprio per il fatto che è un riflesso, però, ci può ricondurre alla Luce diretta che ne è l’intima causa, l’Essenza.
La sofìa è quindi pienamente attingibile solo in uno spazio sacro, trans-umano, metafisico; essa è la stessa ‘sacra sapienza’ che si acquisiva in Grecia all’interno dei culti misterici con lo stato illuminativo della epoptéia.
Ecco perché la pratica filosofia e quella misterico-iniziatica hanno per Socrate e per Platone il medesimo fine e la filosofia stessa può essere considerata aspirazione, preludio o via a quel Sacro Sapere.
L’esperienza mistica è così il ‘naturale’ approdo della ricerca razionale e non la sua negazione.
Tale idea già propria, quindi, del ‘vangelo socratico’ sarà solo messa per iscritto ed esplicitata da Platone e soprattutto da Plotino.
Se Socrate e Platone vengono ‘letti’ così , molte ‘contraddizioni’ del loro pensiero vengono di fatto spiegate e superate.
A differenza di quanto molti hanno pensato, Platone non tradisce il suo Maestro volgendosi verso la metafisica; ne è, al contrario, il più acuto interprete e fedele seguace.
5 – SOCRATE ED IL DEMONE ‘AMORE’
Se Socrate è maestro di dialettica è invece, per quanto detto, un semplice (pur se straordinario) allievo nei confronti del Sapere Sacro e di chi lo detiene.
E infatti come tale si considerava, secondo la famosa testimonianza di Platone nel Simposio.
La testimonianza di Platone è esplicita: quando Socrate vuole acquisire un sapere non più solamente ‘umano’ si rivolge al sapere esoterico-iniziatico.
Uno dei più profondi segreti iniziatici, quello concernente la natura ‘demonica’, cioè ‘metafisica’, dell’Amore ( dunque anche di quella specie di amore che ci spinge alla Conoscenza) gli è rivelato da una sacerdotessa dei culti misterici, Diotìma di Mantinea, la quale – significativamente – esita a comunicarne a Socrate il segreto supremo perché non è sicura che egli abbia le qualità e le capacità richieste per essere iniziato.
E’ evidente che le doti che Diotìma ritiene necessarie non sono quelle ‘speculative’, perché in esse il filosofo eccelleva quanto nessun altro, ma altre, cioè quelle ‘etiche’, ‘sottili’, ‘animiche’, cioè quelle ‘virtù’ che denotano un animo ‘nobile’, non contaminato da abiti istintivi e passionali, e per ciò stesso capace di sublimare i suoi appetiti e le sue emozioni.
Se infatti la razionalità è pienamente posseduta, e non solo predicata, essa si traduce in un dominio sulle passioni tale da divenire un abito comportamentale e da determinare un cambiamento ‘ontologico’ della coscienza, una metànoia.
Le qualità intellettuali e quelle morali devono essere totalmente congiunte e si potrebbe dire con linguaggio socratico che solo quando ciò accade l’anima è ‘gravida’ per l’iniziazione: così come pochi sono qualificati per essere ‘iniziati alla filosofia’ ancor meno lo saranno per la ‘sofìa’.
Tale presupposto ‘esistenziale’ e ‘qualitativo’ lo si capirà bene proprio quando Diotìma rivelerà che il segreto d’Amore per essere svelato comporta la capacità nell’iniziato di svincolare l’Eros dalla sua dimensione ‘volgare’, cioè passionale, corporea, biologica per sublimarlo a livello metafisico.
La rivelazione della sacerdotessa non è un fatto ‘verbale’e ‘concettuale’ non è una ‘nozione’ma fa riferimento e deve tradursi in effetti in una ‘esperienza’ illuminativa.
Un animo raffinato e ‘puro’ potrà salire – e sol’esso – la scala dell’Amore sino all’Amore per il Bello e per il Bene, cioè ad un Amore del tutto metafisico e svincolato dal corporeo e per ciò stesso più intenso e beatificante.
Il Bene (termine che indica la relazione dell’Uno con noi e di cui il Bello è solo un ‘riflesso’ in questo mondo materiale) è proprio il nome del Dio di Platone, che in tal modo lo svincola senza equivoci da ogni antropomorfismo volgare.
Il discorso sull’Amore di Diotìma si può considerare come la ‘summa iniziatica’ del mondo antico e non a caso produrrà, anche molti secoli dopo, straordinari effetti nella storia della cultura occidentale.
Quella dottrina che non vedeva nell’amore corporeo un ‘peccato’ ma solo una fase ancora ‘immatura’ dell’amore verso il divino (in qualche modo, dunque, un necessario ‘preludio’), aiuterà la cultura umanistico-rinascimentale italiana a svincolarsi dal trascendentimo fideistico medievale: basti pensare agli ‘eroici furori’ di Giordano Bruno.
E’ da Diotìma, cioè dalla tradizione misterica, che Socrate apprende che l’Amore nella sua essenza (e al di là di tutte le sue forme) è tensione verso l’Uno, Il Bene, il Divino.
L’uomo vuole ‘fondersi’ amorosamente ed estaticamente con il Tutto, con l’Anima segreta dell’Universo: è questo quello che inconsapevolmente cerca ogni volta che sente urgere in sé la tensione amorosa.
L’Amore così è una forza ‘demonica’, la cui funzione – appunto – è quella di porre in collegamento il piano umano con quello divino.
“L’Eros – dice Diotima - è un possente dèmone, o Socrate, che come tutti i dèmoni sta tra il divino e l’umano…da lui procede tutta l’arte della divinazione, tutta la scienza sacerdotale per quel che riguarda i sacrifici e le iniziazioni e poi gli incantesimi, ogni sorta di profezia e la magia. Dio non scende a contatto con l’uomo ma è attraverso i demoni che egli parla ed ha rapporto con gli uomini, sia quando sono svegli, sia durante il sonno; e chi è sapiente in queste cose è un ispirato…”(Symp., 203a).
L’Amore è per Diotìma ‘filosofo’ per sua natura, è una forza che non dà Conoscenza ma ci spinge a perseguirla, dunque non è ‘sapiente’(cioè è ancora un ‘tendere’ verso il Vero) a non è neanche ‘ignorante’ (cioè in qualche misura ed in qualche modo ‘intuisce’ la Verità e procede verso di essa).
L’Eros ‘filosofo’ ci fa aspirare al Bello e da questo al Bene ed al Vero.
Di fronte a questo profondo e sottile segreto metafisico dell’Amore Socrate ammette la sua ‘umana’ ignoranza e per questo confessa con umiltà alla sacerdotessa: “E’ per questo che io vengo da te, ben sapendo che io ho bisogno di maestri”.
Dunque esiste un sapere più alto a cui Socrate con tutta la sua abilità dialettica non ha accesso: è il sapere ‘religioso’, il ‘sapere sacro’ dei misteri orfici ed eleusini, accolto e fatto proprio dalla scuola pitagorica.
E’ un sapere che presuppone qualità interiori particolari tanto che Diotìma esprime apertamente le sue perplessità circa la qualificazione del ‘discepolo’ ed ‘allievo’ Socrate dicendo: “Fino a queste cose d’amore forse, o Socrate, anche tu potrai essere iniziato; ma a quelle perfette e alle più alte iniziazioni cui tendono anche queste, se si procede in modo giusto, non so se tu saresti capace di essere iniziato. Parlerò allora io e metterò tutto il mio impegno, e tu cerca di seguirmi, se ne sei capace” (Symp., 209e).
E’ solo dopo tale ammonizione che Diotìma rivela a Socrate come si possa arrivare al punto culminante dei misteri d’Amore e rivela come esso corrisponda alla visione ‘epoptica’ del Bello in sé, cioè di una pura e sublime ‘luce spirituale’.
Eros è filosofo, quindi; esso ci spinge e guida alla Conoscenza metafisica poiché anche frammentato ed oscurato dal corpo nelle singole individualità umane, Esso è Forza cosmica che, pur radicata nel corpo, volge allo Spirito.
La filosofia è Amore, Amore per la Conoscenza; ma, poiché l’amore è desiderio di fondersi con ciò che si ama, il vero filosofo desidera ricongiungersi all’Uno-Tutto attraverso un processo dapprima ‘logico’, cioè di esterna comprensione concettuale della Realtà, e poi ‘ontologico’, di identificazione e fusione mistica con l’Essenza di Essa.
L’anima quando scopre la sua vera natura e diviene ‘illuminata’ trascende la sua individualità ‘storica’, si riconosce e si sente come tutt’una con l’Uno-Tutto.
La conoscenza mistica abbatte la separazione tra soggetto ed oggetto, tra finito ed infinito, tra ciò che è ‘umano’ e ciò che è ‘divino’ perché è conoscenza per identificazione e per identità sostanziale che supera i limiti del corporeo e del sensibile.
Così anche per Socrate – e non solo per Platone- la filosofia è solo il necessario preludio ed avviamento al sapere sacro a cui la semplice logica umana non conduce: è Eros-Sofìa.
E questo è l’insegnamento più alto dei Misteri che Diotìma offre all’allievo Socrate.
Quando, pertanto, la ragione, svolgendo la sua funzione ‘protrettica’ (da protrépo che significa ‘spingere avanti’) arriva ai suoi naturali limiti (conoscendo le leggi ‘meccaniche’ del mondo naturale e fondando eticamente la polis) avverte il Mistero sterminato che lo circonda.
Tuttavia sa anche che da esso proviene ed in esso riconfluirà con la morte.
Ma l’uomo non è totalmente solo perché dal profondo di quel Mistero una qualche voce ‘divina’ può giungerci.
A quella ‘dimensione’ appartiene quella stessa ‘entità demònica’ che Socrate ebbe il dono di ascoltare sin da piccolo.
E’ il dèmone la sua guida verso il Mistero che per la ‘logica’ umana tutta costruita sulla percezione sensibile sarà sempre inaccessibile.
Per questo Socrate non propone una sua ‘dottrina’ metafisica perché i nostri parametri concettuali sono del tutto inadeguati e fallaci per quella realtà.
Egli sa tuttavia che si apre uno spiraglio verso la Conoscenza quando l’uomo ‘si prende cura della sua anima’, cioè volge la sua ricerca verso il mondo dello spirito alimentando le sue più nobili aspirazioni.
Allora il Mistero diviene una luce che poco a poco illumina di conoscenza l’anima, conoscenza che si nutre di silenzio fisico e mentale, d’interiorizzazione.
6 – IL COMPITO DELLA FILOSOFIA E LA MORTE INIZIATICA
Socrate con la sua dialettica intendeva effettivamente avviare i suoi interlocutori a fare esperienza della loro ‘anima’ e ad aver cura di essa come della cosa più preziosa.
Aveva altresì ‘fede’ e ‘speranza’ che essa fosse di origine ‘sovrannaturale’ e che avesse un destino oltremondano, cosicché la sua unione col corpo fosse solo provvisoria; riteneva inoltre che da tale unione derivassero per l’uomo i più grandi dolori e le più gravi illusioni.
Solo con la ‘catarsi’ da vivi ed infine con la morte, l’anima può recuperare la sua essenza distaccandosi dal corpo/carcere/tomba.
La sua, quindi, era la fede degli orfici e dei pitagorici, della tradizione esoterica greca.
Va da sé, tuttavia, che tale ‘fede’ rimaneva una credenza intima e personale ed il filosofo era del tutto consapevole del fatto che non poteva per sua stessa natura tradursi in una dottrina ‘dogmatica’, ‘esclusivista’, cieca ed intollerante, tantomeno poteva essere fossilizzata in un libro sacro o ‘gestita’ da una istituzione.
Per Socrate l’accesso al sacro è possibile a qualsiasi essere umano perché la porta ad esso è la sua stessa coscienza.
La Vita Religiosa, l’accesso alla Salvezza, all’Illuminazione alla Conoscenza, alla Grazia, comunque si voglia definire o qualificare, dai diversi punti di vista, la realizzazione della dimensione metafisica dell’anima non hanno bisogno di mediatori, redentori, salvatori, messia, chiese.
Il Socrate ‘storico’ fu quindi un Socrate ‘mistico’ e come tutti i mistici parla della vita spirituale e della dimensione metafisica perché esse siano ‘realizzate’ e non rimangano puro concetto, cioè pura ‘rappresentazione’.
Inoltre, come tutti i mistici, fu ‘scettico’ nei confronti di qualsiasi dottrina che presuma di poter definire e ‘cristallizzare’ l’esperienza del Sacro, di per sé ineffabile.
Egli non aveva una ‘fede’ assoluta e conchiusa nella razionalità e nel dialogo; non voleva collocarsi univocamente nell’orizzonte umano della razionalità. Egli più di tutti sa che la ragione ha i suoi limiti.
Questa struttura di pensiero è particolarmente evidente nel Gorgia, nel Menone, nel Fedone.
Nel Fedone è esplicitamente condivisa da Socrate non solo la dottrina orfica sull’anima ma anche la speranza che ne deriva, grazie alla quale il filosofo affronta la morte con serenità.
Egli è consapevole di esser vissuto tenendo il suo spirito lontano dai puri piaceri del corpo seguendo al meglio delle sue possibilità la ragione.
Questa è quella facoltà ‘divina’ che consente all’uomo di controllare istinti e passioni radicati nel corpo dando loro una giusta misura attraverso la virtù della temperanza (sofrosyne).
“Sembra che ci sia un sentiero (quello filosofico) che ci porti, mediante il ragionamento, direttamente a questa considerazione: che, cioè, fino a quando noi possediamo il corpo e la nostra anima resta invischiata in un male siffatto, noi non raggiungeremo mai in modo adeguato ciò che ardentemente desideriamo, vale a dire la verità. Infatti il corpo ci procura innumerevoli preoccupazioni per la necessità del nutrimento; e poi le malattie, quando ci piombano addosso, ci impediscono la ricerca dell’essere. Inoltre, esso ci riempie di amori, di passioni, di paure, di fantasmi di ogni genere e di molte vanità, in modo che, come suol dirsi, veramente per colpa sua, non ci è neppure possibile fermare il nostro pensiero su alcuna cosa. Infatti guerre, tumulti e battaglie non sono prodotti da null’altro se non dal corpo e dalle sue passioni. Tutte le guerre nascono per brama di ricchezze, e le ricchezze noi dobbiamo di necessità procacciarcele a causa del corpo, essendo asserviti ai bisogni del corpo. E così noi siamo distolti dalla filosofia, per tutte queste ragioni. E la cosa peggiore di tutte è che, se riusciamo ad avere dal corpo un momento di tregua e riusciamo a rivolgerci alla ricerca di qualche cosa, ecco che, improvvisamente, esso si caccia in mezzo alle nostre ricerche e, dovunque, provoca turbamento e confusione e ci stordisce, sì che, per colpa sua, noi non possiamo vedere il vero. Ma risulta veramente chiaro che, se mai vogliamo vedere qualcosa nella sua purezza, dobbiamo staccarci dal corpo e guardare con la sola anima le cose in se medesime. E allora soltanto, come sembra, ci sarà dato di raggiungere ciò che vivamente desideriamo e di cui ci diciamo amanti, vale a dire la conoscenza suprema: cioè quando noi saremo morti, come dimostra il ragionamento, mentre, fin che si è vivi, non è possibile…E nel tempo in cui siamo in vita, come sembra, noi ci avvicineremo tanto più al sapere quanto meno avremo relazioni col corpo e comunione con esso, se non nella misura in cui vi sia imprescindibile necessità, e non ci lasceremo contaminare dalla natura del corpo…Se queste cose sono vere grande speranza ha colui che giunge là dove io sto per andare, di venire in possesso, là appunto e pienamente, se mai in qualche luogo è possibile, di ciò per cui ci siamo dati tanto da fare nella vita passata; così che questo viaggio nell’al di là, che mi viene ora comandato, si compie con buona speranza, e per me e per chiunque altro ritenga di aver preparato la sua mente a questo in modo da averla purificata… E la purificazione, come è detto in una antica dottrina, non sta forse nel separare il più possibile l’anima dal corpo e nell’abituarla a raccogliersi e a restare sola in se medesima, sciolta da vincoli del corpo, e a rimanere per il tempo presente e futuro sola in se medesima, sciolta dal corpo come da catene?…E a scioglierla si adoperano sempre, più di tutti, i veri filosofi e, anzi, solo i veri filosofi; e precisamente questo è il compito dei filosofi: sciogliere e separare l’anima dal corpo” per cui “ la morte, a loro, fa molto meno paura che a qualunque altro uomo” (66 b-67d-e).
Per Socrate il sapere filosofico, così, è la base di ogni virtù e questa è in grado di compiere quella purificazione dalle passioni del corpo che pone l’anima in condizione di pervenire alla conoscenza suprema, parzialmente e provvisoriamente da vivi, totalmente e definitivamente da morti: “ la virtù vera non è che una purificazione dalle passioni” cosicché “la temperanza, la giustizia, il coraggio e il sapere medesimo non sono altro che una specie di purificazione”(69 c).
Anche in tal caso, cioè nel considerare l’aspetto propriamente etico della vita spirituale (intimamente connesso, dunque, a quello metafisico), Socrate dimostra di condividere in pieno la visione della tradizione esoterica, l’unica capace oltretutto di fondare per lui una ragionevole speranza di giustizia nell’al di là.
Socrate è molto esplicito circa il senso da dare alla riflessione sulla morte che deve accompagnare la vita del saggio e che non si tratti di un semplice ed intellettualistico considerare la ‘terrena’caducità della cose e degli affetti per il semplice ed emotivo aspirare ad un a condizione diversa lo si capisce bene in quel passo del Fedone in cui parla della ‘tecnica meditativa’ attraverso la quale l’anima si deve disporre all’ultimo viaggio: bisogna allenarsi nel corso della vita a separare la coscienza dalle percezioni sensibili, isolare l’anima, unificarla per consentire ad essa di manifestare la sua vera natura (che è anche la nostra essenza!).
Esercitandosi con tale prassi essa diviene capace d’entrare in una condizione di pace e stabilità interiore, lontana dalla sofferenza connaturata al nostro mondo, quello dell’impermanenza, quello del Tempo che divora mostruosamente i suoi figli.
A tal punto essa, svincolatasi dalle catene che la trattenevano in Basso, si volge verso l’Alto, si quieta e raggiunge finalmente la Conoscenza del Mondo Spirituale da cui in realtà proviene e di cui sente una profonda nostalgia.
La prassi filosofica consiste quindi propriamente nel radicare l’io nella trascendenza, nel ‘desomatizzarlo’, esattamente come nella tradizione iniziatica di tutti i tempi e di tutti i luoghi.
Egli infatti così dice ai suoi interlocutori: “Quando l’anima si avvale del suo corpo per fare qualche indagine, servendosi della vista o dell’udito o di altra percezione sensoriale (infatti far ricerca per mezzo del corpo significa far ricerca per mezzo dei sensi), allora essa è tratta dal corpo verso le cose che non permangono mai identiche ed erra e si confonde e barcolla come ubriaca, perché tali sono appunto le cose a cui si attacca…ma quando l’anima, restando in sé sola e per sé sola, svolge la sua ricerca, allora si eleva a ciò che è puro, eterno, immortale, immutabile. E avendo natura affine a quello, rimane sempre con quello, ogni volta che le riesca essere in sé e per sé sola. E allora cessa di errare e in relazione a quelle cose rimane sempre nella medesima condizione, perché immutabili sono quelle cose alle quali si attacca. E quello stato dell’anima si chiama Sapienza (frònesis, termine che Platone usa sovente come sinonimo appunto di sophìa)” (Fedone,79 c-d).
La tecnica meditativo-estatica a cui Socrate e Platone fanno riferimento costituisce l’essenza stessa del percorso iniziatico e ne rivela in qualche modo il segreto: separando la coscienza (l’anima) dal corpo già in vita, ‘isolandola’ dal mondo esterno si anticipa ‘realmente’, cioè ‘sperimentalmente’ il processo stesso della morte ( la quale è ‘letteralmente’ il distacco ‘definitivo’ della psiché dal sòma).
Inoltre, grazie a tale ‘operazione’si ‘conosce’ la natura metafisica, ‘divina’, della nostra coscienza e la dimensione metafisica a cui lo spirito perverrà dopo la morte, cioè a ‘distacco’ avvenuto.
La prassi iniziatica, l’esercizio meditativo, la filosofia stessa non sono altro così che un prepararsi alla morte per poterla affrontare poi, nell’estremo momento del trapasso con una più luminosa speranza, quasi con la certezza di un destino di trasfigurazione beatifica.
L’estasi mistica, a cui si perviene attraverso un corretto uso della ‘dialettica’, è un provare da vivi l’esperienza della morte: la parola stessa lo dice perché essa significa ‘uscita’ (dal corpo…).
Il filosofo ed il mistico al momento della morte non vengono turbati nello spirito come accade ai ‘non iniziati’ perché a quel processo di separazione sono già adusi; sono in qualche modo in grado di controllarlo, ‘sanno’ di poter sopravvivere con il loro principio cosciente.
Socrate stesso è un concreto e luminoso esempio di come si possa e si debba, da iniziati/filosofi affrontare la morte ed è lui stesso a motivare in tal senso la sua ‘sovrumana’ serenità rivolgendosi ai discepoli che lo attorniano nel momento estremo della vita.
Ma se il ‘segreto’ dei Misteri è il segreto della morte e della vita che segue è un segreto che non può essere per sua stessa natura ‘comunicato’, ‘raccontato’.
Diventa manifesto, ‘reale’ e ‘comprensibile’ solo quando lo si vive per quello che realmente è: un processo di radicale e coinvolgente trasformazione; esso, però, è di per sé pericoloso perché ‘da vivi’ bisogna apprendere a ‘morire’ e a ‘rinascere’, cioè ritornare nel corpo dopo aver fatto esperienza del ‘mondo degli dèi’.
E’ un’esperienza a cui bisogna essere preparati e per cui bisogna essere ‘qualificati’ (così ammoniva la tradizione misterica…) perché potenzialmente ‘sconvolgente’: solo le persone cha hanno piena padronanza di sé ed alti intenti possono affrontarla senza riceverne danno.
Per questo è perfettamente comprensibile il fatto che Socrate, quando condanna il formalismo religioso, lo faccia proprio rifacendosi alla tradizione orfica di cui egli stesso si considerava ‘seguace’. Cita infatti un detto orfico il quale affermava che i portatori di tirso (simbolo della devozione a Bacco) sono molti ma i veri ‘Bacchi’(cioè le persone autenticamente capaci di vivere una vita ‘divina’ e di ‘sentire il dio in sé’) sono pochi, cosicché poco prima di morire può dichiarare la sua buona coscienza nella ricerca religiosa e fondare su di essa la sua serenità: “E certamente non furono degli sciocchi coloro che istituirono i Misteri: e in verità già dai tempi antichi ci hanno velatamente rivelato che colui il quale arriva all’Ade senza essersi iniziato e senza essersi purificato, giacerà in mezzo al fango; Invece, colui che si è iniziato e si è purificato, giungendo colà, abiterà con gli Dei. Infatti, gli interpreti dei misteri dicono che ‘i portatori di ferule sono molti, a i Bacchi sono pochi’. E costoro, io penso, non sono se non coloro che praticano rettamente la filosofia. E anch’io, per essere fra questi, non ho tralasciato nessuna cosa in vita mia, per quanto mi fu possibile, anzi vi ho messo ogni mia cura”. (69 b-d).
Dunque la pratica filosofica ha il medesimo fine catartico ed illuminativo dei culti e dei riti misterici; anzi, ne rappresenta in qualche modo l’essenza.
Errano pertanto gravemente tutti gli studiosi che pretendono di cogliere una differenza sostanziale tra la kàtharsis orfica che utilizzava pratiche rituali e quella del tutto ‘spirituale’, interioristica e ‘speculativa’di Socrate e Platone.
Infatti per gli antichi il rito è efficace e ben eseguito se si ‘manifesta’ come un’operazione ‘esterna’ che sostiene e stimola un’operazione ‘interna’.
Se invece i moderni l’intendono solo come una vacua ed inefficace cerimonialità, ciò dimostra solo l’esistenza di un pregiudizio e di una ignoranza universalmente diffusa, tipica della forma attuale della nostra civiltà ‘occidentale’.
E’ ben noto il fatto che le concordi testimonianze antiche circa i riti ed i culti misterici fanno sempre riferimento alla induzione negli iniziati di ‘esperienze’ di morte e rinascita, cioè di separazione e ricongiungimento della coscienza dal corpo e col corpo.
Solo con un ‘viaggio fuori dal corpo’, cioè con una ‘morte temporaneamente indotta’( che si manifestava evidentemente ‘all’esterno’come catalessi estatica) l’iniziato si convinceva dell’esistenza del mondo metafisico e del destino oltremondano della sua anima che, pur svincolandosi dal corpo attraverso il ‘misterioso’ rito, manteneva la sua consapevolezza.
Ritornato al corpo, ‘rinato’, l’iniziato nasceva ad una nuova vita.
Per lui la morte non aveva più il truce volto del terrore ma quello della serena speranza.
Si pensi alla celebri testimonianze di Plutarco ed Apuleio.
Il primo scrisse: “ E giunta alla morte l’anima prova un’emozione come quella degli iniziati ai grandi misteri” (fr.178; Colli, 3 –B 4 a) ed il secondo :”Raggiunsi il confine della morte, dopo aver varcato la soglia di Proserpina fui condotto attraverso tutti gli elementi, e ritornai indietro” (Metamorfosi, II, 23; Colli, 3- B 4b).
E Pindaro: “Felice chi entra sotto la terra dopo aver visto quelle cose: conosce la fine e lo scopo della vita, conosce anche il suo inizio ed il fondamento datole da Dio” (fr. 137; Colli, 3 – A2).
L’amore per la Conoscenza ha la virtù di trasfigurare e sublimare l’Eros, il Logos è la guida sicura di tale processo trasformativo.
Come Socrate-Platone diranno nel Simposio, volgere l’Eros verso l’Alto, ‘smaterializzarlo’, ‘purificarlo’ significa procedere verso l’Uno che per noi esseri umani finiti si pone come il Bene stesso.
In tale passo Socrate afferma con chiarezza la virtù catartica dell’attività riflessiva, del ragionamento che per essere condotto correttamente deve svincolarsi non solo dal percepire, ma deve acquisire pienamente la capacità di ‘astrazione’ e di ‘concentrazione’.
Questa consiste appunto nella capacità di ‘abs-trarsi’ (dal latino abs-traho) cioè appunto di ‘separarsi dal’ puro piano del sensibile non solo per elaborare dei concetti ma per poter, sulla stessa linea di sviluppo,entrare nel piano metafisico delle ‘pure’ forme, il platonico mondo delle idee.
Il processo razionale condotto correttamente assume una valenza ‘sacrale’.
Questo è il segreto della ‘dialettica’.
Non c’è soluzione di continuità tra la riflessione astrattiva e la visione metafisica: questa è il ‘naturale’ sviluppo della prima.
La riflessione astrattiva quando ha finito il compito, quando ha esaurito tutte le sue possibilità si traduce in pura aspirazione conoscitiva che non si fa mediare più dalla mente discorsiva.
Tale aspirazione è una forza capace di spingere l’anima al di là del mondo sensibile.
Questo ‘passaggio’ avviene quando la mente ha esaurito tutte le sue possibilità ma il desiderio puro del conoscer la orienta oltre.
La pratica del raccoglimento interiore attraverso il corretto esercizio dell’attività discorsiva è quindi considerata non fine a se stessa ma come una tecnica introduttiva all’estasi separativa.
La pienezza della conoscenza c’è solo quando l’anima è capace di conoscere ‘intuitivamente’ , cioè con i suoi soli ‘sensi’, quando la mente non opera più ‘dialetticamente’ per distaccarsi dal piano fisico ma giunge a ‘vedere’ la dimensione metafisica.
Se la mente tace ma la tensione conoscitiva rimane intatta la Luce entra nell’anima.
Il ‘pensare’ deve preludere al ‘vedere’.
Se il filosofo ‘pensa’, l’iniziato ‘vede’.
Ma se la filosofia è ‘epoptica’, cioè ‘illuminativa’, ha una positiva funzione ‘anagogica’, cioè aiuta a spostare la coscienza verso il mondo metafisico.
Per questo gli antichi definivano la filosofia di Socrate, Platone, Plotino come ‘epoptica’, cioè finalizzata a condurre coloro che la ‘praticavano’ a quel livello di illuminazione, l’epopteia a cui giungevano gli iniziati del terzo grado, quello più elevato.
La speculazione ‘razionale’ se correttamente orientata e ‘vissuta’ come moralità operante e coerenza di vita, si può definire come la vera attività ‘teoretica’, è il theorein nel suo significato originale e pregante di ‘osservare il divino’.
E’ una tecnica ‘estatica’ basata sulla ‘deprivazione sensoriale’ che Socrate personalmente praticava con intensità e costanza, come ci testimonia Platone nello stesso Simposio, quando si separava da tutti e da tutto si fissandosi anche fisicamente nella più assoluta immobilità per periodi di tempo incredibilmente lunghi.
Era la sua ascesi.
Se vogliamo era il suo ‘rito interiore’.
Era l’essenza di quello che si faceva nei riti misterici perché si voleva indurre lo stesso stato di coscienza svincolato dal sensibile.
Anche i saggi delle Upanishad parlavano delle loro pratiche meditative come ‘interiorizzazione del rito vedico’ per superarne il pericolo della formalità esterioristica.
E questa, com’è noto, fu anche la posizione del Buddha.
Era per Socrate il suo ‘yoga’, la sua tecnica di ‘unione’ (yoga significa in sanscrito appunto questo) col divino attraverso la ‘separazione’ dal mondo sensibile e la ‘unificazione’ della coscienza.
Così gli appariva la ’luce dello spirito’.
‘Conoscere se stessi’, diceva Socrate, significa ‘conoscere il divino in noi’.
Ciò è possibile solo se si volge la coscienza verso l’interno.
Per questo il motto della ‘sua’ filosofia è esattamente quello della sapienza iniziatica di Apollo.
La filosofia ‘speculativa’, per Socrate, con i suoi argomenti ‘logici’ non fa altro che dimostrare la possibilità razionale dell’immortalità dell’anima, ma è evidente come anche per Socrate la sola iniziazione dava la prova ‘esperienziale’ di tale possibilità.
Le dimostrazioni e le argomentazioni ‘razionali’ non sono quindi fine a se stesse, come modernamente si vuol sostenere.
E se Socrate vuole conoscere il ‘mistero’ dell’Amore (che ha in sé quello della Vita e della Morte) deve rivolgersi alla sacerdotessa dei culti isterici, Diotìma.
Socrate è solo convinto che anche la filosofia (al di là di ogni pratica ritualistica) di fatto possa tendere e debba tendere allo stessa meta conoscitiva e realizzativa.
E’ un problema di mezzi, nient’altro.
Sul finire della vita proprio colui che ha ‘inventato’ la filosofia come ‘genere letterario’ scrivendo mirabili dialoghi sul suo Maestro che non volle mai scrivere nulla, cioè Platone, raggiunse la convinzione che la scrivere di filosofia è forse solo un tradirla.
Una filosofia che rimanga solo speculazione razionale e gioco di concetti tradisce il suo scopo.
La filosofia è un ‘processo vivo’ che non si può riprodurre o indurre attraverso dei segni grafici.
Nel dialogo orale, nella comunanza di vita tra maestro e discepolo questo deve impegnarsi in prima persona, non può limitarsi a ‘recitare’ un testo già scritto.
Attraverso la sola oralità (che è un modo del ‘segreto’) viene così coinvolto e deve essere genuinamente partecipe della ricerca del vero a cui il maestro l’impegna.
Attraverso il contatto personale e la oralità il Maestro non dirà a tutti le stesso cose, nello stesso modo e nello stesso momento perché il processo conoscitivo ha le sue ‘fasi’, i suoi ‘percorsi’ e solo le anime gravide possono essere aiutate a ‘partorire’.
L’esercizio filosofico non impegna solo la memoria nel ricordare un testo già scritto.
La scrittura crea un equivoco; è pericolosa; è inefficace.
La memoria si può spacciare per conoscenza.
Ma l’esercizio filosofico non ha nulla a che vedere con l’erudizione e col mero esercizio intellettuale.
Solo chi compie quella pratica con tutto se stesso ha speranza di raggiungere il fine; ed il fine non è un concetto, anche il più elevato, quello dell’Uno-Tutto, ma una esperienza, quella grazie alla quale si coglie la Verità dell’Uno con una diretta ed intuitiva apprensione.
Per questo il vecchio Platone sembra ritornare sui suoi passi e dopo aver divulgato la filosofia con i suoi dialoghi tiene un suo corso ‘esoterico’ sul Bene e sull’Uno.
La Settima Lettera è come una sua ‘palinodia’.
Tenendo e dichiarando la impossibilità di mettere per scritto la sua scienza, perché di essa o si ha esperienza personale o risulta del tutto incomprensibile, finisce per invalidare o quantomeno sminuire tutta la sua ingente produzione ‘letteraria’.
Insomma Platone è dovuto ritornare al precetto dei misteri che imponeva il silenzio agli iniziati sia a causa della immaturità delle persone che ‘apprendono’ senza provare, sia a causa della ineffabilità del Principio Primo che si pone oltre il pensiero discorsivo.
Platone lo dichiara esplicitamente proprio nella Settima Lettera.
Questa volta però non riferisce le sue considerazioni attribuendole al Maestro ma evidenzia la sua ‘personale’ esperienza, le sue ‘personali’ convinzioni.
La dottrina, quella vera non può e non deve essere messa per scritto, cioè resa essoterica, ‘non si può in alcun modo comunicare’.
La vera conoscenza è ineffabile, è mistica, cioè impone il silenzio della mente perché essa si coglie quando andiamo oltre la mente discorsiva e solo allora si accende una luce nell’anima.
Le lunghe discussioni, cioè l’esercizio della ragione, la comunanza di vita, cioè l’impegno all’interno di una scuola e a contatto con un Maestro sono solo la preparazione alla vera esperienza.
La conoscenza che Platone voleva trasmettere non era una ‘scienza’ come le altre, quelle che possono esser ‘comunicate’, ‘divulgate’.
La ‘dialettica’ del logos aveva la funzione di propiziare uno stato illuminativo.
Una volta che la luce si è accesa nell’anima essa si sviluppa per sua stessa forza, si ‘nutre di se medesima’, non c’è più bisogno di ulteriori ‘insegnamenti’.
Infatti il ‘divino’ Platone (non è un caso che, tra i filosofi, tale epiteto nell’antichità sia stato riservato a lui) dice:
“Questo tuttavia io posso dire di tutti quelli che hanno scritto e scriveranno dicendo di conoscere ciò di cui io mi occupo per averlo sentito esporre o da me o da altri o per averlo scoperto essi stessi, che non capiscono nulla, a mio giudizio, di queste cose. Su di esse non c’è, né vi sarà alcun mio scritto. Perché non è questa mia una scienza come le altre: essa non si può in alcun modo comunicare, ma come una fiamma s’accende da fuoco che balza: nasce d’improvviso nell’anima dopo un lungo periodo di discussioni sull’argomento e una vita vissuta in comune, e poi si nutre di se medesima”.
Le ‘discussioni’, la vita in comune con i suoi ‘iniziati’ (novella comunità pitagorica…) servono, secondo Platone, solo a propiziare una esperienza ‘indicibile’, uno stato di ‘illuminazione’.
Potremmo insomma dire – mutatis mutandis – e con il conforto del significato letterale delle stesse parole ciò che la filosofia cristiana medievale diceva circa il rapporto tra fede e filosofia: Philosophia ancilla Sophiae.
E’ evidente dal testo del Fedone che per Platone (e, sicuramente, anche per Socrate) non c’era quindi nessuna differenza sostanziale tra la finalità e l’essenza dei riti orfici e la finalità e l’essenza della pratica filosofica: in entrambi i casi si trattava di acquisire la capacità di separare la coscienza da quello stato di ‘fissazione nel corporeo’ che ne impedisce la Conoscenza.
Tale dottrina e tali modi d’introspezione mistica giungeranno intatti nell’età ellenistica, epoca in cui la tradizione esoterica prenderà le forme della gnosi, dell’alchimia, della magia, dell’ermetismo.
APPENDICE: MORTE E RINASCITA MISTICA NELL’ERMETISMO
Alla morte ‘al’ corpo che si può conseguire da vivi con la pratica filosofica (che dunque nella sua essenza è un’ascesi), così come alla morte ‘del’ corpo con cui l’anima si distacca del tutto e definitivamente da esso, segue per gli iniziati (‘rituali’ o ‘speculativi’ che siano) un ‘nascita mistica’, una ‘rinascita’, una ‘rigenerazione’, una ‘palingenesi’ (palinghennesìa).
Tale convinzione ‘esoterica’ a cui corrisponde la pratica della separazione della consapevolezza dalla vita sensibile, percorre intatta la storia della ‘sofìa’ greca, dall’orfismo all’ermetismo dell’età tardo-ellenistica, dal Fedone al Corpus Hermeticum.
In quest’opera, ad esempio, nel XIII Trattato (intitolato ‘Discorso segreto sulla montagna’ di Ermete Trismegisto al proprio figlio Tat) concernente la ‘rigenerazione’ e la ‘regola del silenzio’, è detto con estrema chiarezza che il segreto di quella iniziazione misterica che prende nome dall’antico saggio ( il Mercurio latino, identificato anche con il dio egiziano Thot) è nella ‘rinascita nell’anima’.
Questa avviene solo dopo che l’adepto si è esercitato a chiudere la propria coscienza al mondo dei sensi. Tale deprivazione sensoriale pone l’anima nella condizione di una spontanea crescita; s’innesca, in tal modo, per così dire, un processo di ‘divinizzazione’, avviene per virtù spontanea dell’anima una ‘nascita interiore’, proprio perché sono state sciolte le catene che la vincolavano al mondo sensibile.
Così in effetti prescrive laconicamente il XIII Trattato: “Rendi inattive…le sensazioni del corpo ed allora si avrà in te la nascita della divinità” (katàrgheson tou sòmatos tàs aisthèseis kai éstai è ghènesis tès theòtetos); (XIII, 7).
Sempre nel Corpus, in un altro Trattato intitolato Pimandro, si racconta come Ermete viene a contatto con la divinità solo dopo “aver sospeso i suoi sensi corporei” (I, 1).
Nel Trattato X, poi, intitolato ‘La chiave’, il motivo è ricorrente, anzi si precisa che per aver l’estasi va acquietata anche l’attività discorsiva del pensiero, poiché la speculazione intellettuale è ben altra cosa rispetto all’esperienza diretta; nel silenzio si manifesta la sua ineffabilità: “ Lo vedrai (Dio) quando non avrai più nulla da dire riguardi ad esso, poiché la conoscenza di lui e la sua contemplazione si manifestano come silenzio (siopè) ed inattività di tutti i sensi”(X, 5) (è gàr ghnòsis autoù kai théia siopé esti kai katarghìa pasòn tòn aisthèseon).
Sempre nel Pimandro la ‘rigenerzione’, la ‘palingenesi’ che consegue dalla esperienza mistica trasforma l’uomo, lo ‘divinizza; si usano per indicare tale cambiamento espressioni come ‘nascere in Dio’(èn teò ghìnestai) o ‘essere generato in Dio’(theothènai) (I, 26).
Tale cambiamento è il fine della gnosi che innalza l’uomo a Dio (apotheòsai) (IV, 7).
I trattati ermetici affermano con chiarezza quanto Socrate e Platone avevano teorizzato circa la ‘divinità’ del pensiero, del logos, del nous, il quale ha la capacità di ‘attrarre con un atto di volontà la forza del Dio in sé: “…attiralo a te e verrà; se lo vorrai, ciò avverrà” (epìspasai eis eautòn, kai eleùsetai, théleson kai ghìnetai) (XIII, 7).
Nel Trattato XII, intitolato ‘Sull’intelletto comune’ si afferma che ciò che dobbiamo considerare ‘divino’ negli uomini è proprio la coscienza (oùtos dé o noùs en anthròpois theòs esti) ed è grazie a tale metafisico principio che alcuni uomini sono ‘dei’(kai tinès tòn anthròpon theoì eisin) (XII, 1).
Sempre nel fondamentale XIII Trattato (X) la correlazione tra purificazione misterica e rigenerazione morale è ben esplicitata: l’iniziato, dopo aver allontanato da sé le Dodici potenze del male, i dodici vizi che lo degradano, avendo ‘invocato’ ed ‘incorporato’ la Decade delle virtù, trascende la condizione corporea e rinasce a nuova vita percependo la propria intima divinità: “All’arrivo della Decade –vi si scrive- avviene in noi la ‘generazione spirituale’ (noerà ghénesis)” che ci rende ‘figli di Dio’.
Le Dodici ‘punizioni’ che degradano lo spirito dell’Uomo sono: l’ignoranza, l’afflizione, l’incontinenza, la concupiscenza, l’ingiustizia, il desiderio di sopraffazione, l’inganno, l’invidia, la frode, la collera, l’avventatezza, la malvagità. Tali vizi, si dice, “attraverso quella prigione che è il corpo costringono l’uomo interiore a soffrire per mezzo dei sensi”. Ciò ha fine solo con la ‘discesa del Logos di Dio in noi.
Una nuova nascita, dunque, tale che “chiunque abbia ricevuto la grazia di questa nascita secondo Dio (òstis oun étuche katà tò éleos tès katà thòn ghenéseos) avendo lasciata la percezione del proprio corpo (tèn somatikèn aìsthesin katelipon) riconosce se stesso come un’essenza costituita da queste Potenze divine, le Dodici, e ne gioisce.
—————-
Queste brevi note sono, a nostro avviso, tuttavia sufficienti a farci comprendere come la ‘scienza sacra’ sia stata trasmessa da generazione a generazione dalla più remota antichità sino ai nostri giorni e come anche Socrate abbia dato un contributo importante a che tale trasmissione avvenisse nella Grecia del suo tempo.
Platone, continuandone l’opera spirituale nel solco della Tradizione esoterica, lo ha reso immortale con i suoi scritti.